Un concorso di idee per mantenere viva una memoria critica e autocritica del Castello di Sassari, di Federico Francioni
Sassari,
una città con la tendenza a buttarsi via.
Quanto ci hanno fatto sapere Ponzeletti e Sanna può contribuire ad un dibattito
e ad una riflessione su una città che in diversi momenti storici ha dimostrato
scarsa autostima, come succede nei contesti caratterizzati da una subalternità,
anche culturale, retaggio di una dipendenza di stampo coloniale. Si pensi, per
fare solo due esempi, all’abbandono del centro storico e, di contro,
all’insensata antropizzazione del territorio, perseguita, fra l’altro, con le
colate di cemento a Predda Niedda. Ma si sa, la centralità e la preponderanza
dell’edilizia, in assenza di uno sviluppo economico autocentrato, è una
maledizione del sottosviluppo, funzionale allo sviluppo della metropoli esterna
di volta in volta dominante, conseguenza di secoli di colonialismo; non occorre
necessariamente fare proprie le categorie dei marxisti latinoamericani per accertarlo
e sostenerlo. Si pensi inoltre alla Sardegna come “laboratorio di storia
coloniale”, interno all’Europa, definizione che si deve allo storico
franco-americano John Day, grande e sincero amico della nostra isola.
In
tale contesto va individuata e focalizzata una precisa scala di responsabilità,
a partire dai ceti dirigenti cittadini – fatte, s’intende, le debite eccezioni
per alcune singole personalità e gruppi e per le loro scelte controcorrente –
che hanno contribuito a creare e a perpetuare una cultura della terachia, indifferente ai beni e alle risorse collettive.
Come si arrivò all’abbattimento del Castello. Il caso della demolizione del Castello è esemplare: basta ripercorrere, sulle tracce di quanto hanno detto egregiamente Ponzeletti e Sanna, alcune tappe che condussero a quella scellerata opzione. Nel 1842 alcuni esponenti della borghesia commerciale sassarese – Bargone, Rau e Valdettaro – chiesero al Comune che fosse abbattuta una delle cinque torri del Castello, che incombeva sulle loro case (lo riporta Enrico Costa nella sua insostituibile opera su Sassari); ma l’Amministrazione rispose con un netto rifiuto. Nel 1869 però questo atteggiamento fu capovolto: ebbero infatti la meglio i settori del commercio e dell’edilizia, ma erano in campo anche le gerarchie militari che premevano per la costruzione della caserma, intitolata poi ad Alberto Ferrero Della Marmora.
Per
approdare a siffatta decisione furono sufficienti, oltre agli interessi tipici
di una borghesia del sottosviluppo, lo stato di degrado del Castello, il
giudizio negativo sui secoli delle dominazioni catalano-aragonese e spagnola,
nonché quello sull’Inquisizione che
ebbe sede nello stesso edificio dal 1563 al 1717 (cfr. F. Francioni, La caduta dell’inquisitore. Momenti,
problemi e figure di storia dell’Inquisizione spagnola in Sardegna dal
Cinquecento ai primi del Settecento,
Edizioni della Fondazione Sardinia, Cagliari, 2022, pp. 47-56).
Non
si manifestarono opposizioni significative e consistenti: a parte il prima
ricordato voltagabbana del Comune, lo stesso Costa, storico e poligrafo, cui
certo non difettava l’amore per la sua città, ebbe un atteggiamento ondivago. Da
una parte, egli scrive che il Castello serviva ai governanti catalano-aragonesi
ed ai loro successori non tanto contro nemici esterni, quanto per mantenere
sotto stretto controllo la cittadinanza sassarese: da questo punto di vista,
egli aggiunge, è “un bene che lo abbiamo atterrato” (Sassari, vol. I, p. 127); d’altra parte, egli qualifica la
delibera assunta dal Comune come “insensato progetto” (cfr. Sassari, vol. II, p. 821). Costa, ma non è stato il solo,
si dimostra comunque incapace di distinguere fra il valore storico, artistico e
architettonico di un manufatto e l’uso cui è stato adibito. In mancanza di
questa distinzione, tanti monumenti dell’antichità dovrebbero essere cancellati.
Su
“La Stella di Sardegna” – il vivace settimanale che Costa diresse e pubblicò
dal 1877 al 1886 – non apparvero articoli contrari all’abbattimento della
fortezza, come risulta da un articolo di Salvator Angelo De Castro e da un
altro firmato con lo pseudonimo di Teodolite (entrambi gli scritti sono del
marzo del 1877).
Dal
suo canto Giovanni Spano, eminente archeologo, storico, rettore dell’Università
di Cagliari, senatore del Regno, si limitò a chiedere che venissero salvati
dalla distruzione i cinque stemmi che decoravano la torre centrale del Castello
e quella del campanone. Dunque non solo il ceto borghese, ma anche esponenti
dell’intellettualità cittadina dimostrarono di non avere consapevolezza alcuna
dello scempio che si andava consumando. Fra i pochi oppositori va ricordato
Giovanni Antonio Sanna, imprenditore e collezionista di opere d’arte, che
riuscì ad inserirsi nel ristretto novero dei capitalisti europei impegnati
nello sfruttamento delle miniere isolane. Egli, fra l’altro, commissionò al
pittore Giuseppe Solinas un acquerello raffigurante la fortezza (è stato
pubblicato nella copertina del volume di Paolo Fadda, L’uomo di Montevecchio. La vita
pubblica e privata di Giovanni Antonio Sanna il più importante industriale
minerario dell’Ottocento, edito
nel 2010).
Ieri
l’abbattimento del Castello, di recente il disegno di distruggere le valli con
i loro ecosistemi. Dopo la
distruzione del Castello, realizzata dal 1877 al 1880 – anche con il ricorso
alla dinamite, inventata da Alfred Nobel nel 1867 – il ceto dirigente sassarese
ha fornito un’altra prova di assoluta mancanza di cura per i beni e le risorse
della nostra comunità: ci riferiamo all’atroce progetto della Giunta guidata da
Nanni Campus per desertificare il Fosso della noce e per sostituirlo con un
canalone di cemento, lungo circa 900 metri, largo più di 7, adducendo la
giustificazione di un rischio idrogeologico, peraltro sopravvalutato; un obiettivo
bloccato dai Comitati di quartiere e da una vittoriosa mobilitazione popolare (si
veda il documentato resoconto di Nello Bruno su “Camineras”, n. 9, 2024, pp.
39-48).
Un particolare del barbacane del Castello, rinvenuto con gli scavi del 2008 - 2010


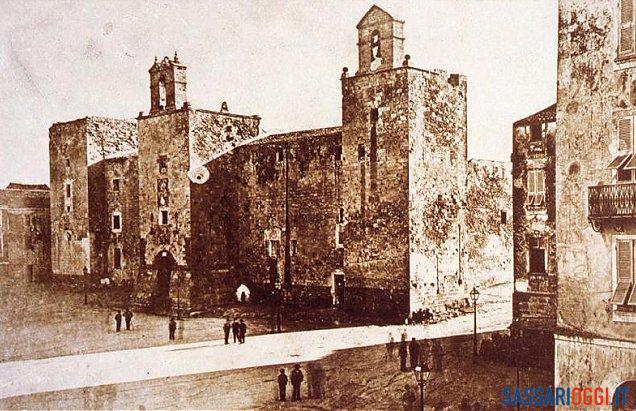

Commenti